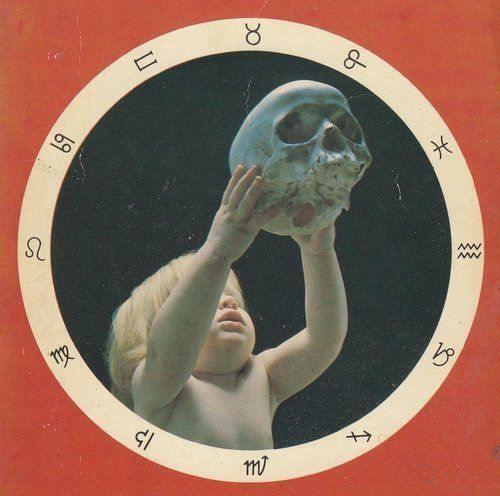
Nel nostro tempo, quello che il filosofo francese Lyotard ha definito postmoderno, tutto sembra darsi nella dimensione del frammento. Ogni aspetto della realtà è divenuto complesso, multisfaccettato, multidirezionale e l’apertura al mondo ci appare poliedrica e multiforme. Saperi ed attività umane si sono andate approfondendo e differenziando secondo uno schema di specializzazione/settorializzazione che ci appare, oggi, come un percorso irreversibile e inarrestabile.
Le ricerche e i saperi si sono a tal punto diversificati e ramificati, in relazione alle conquiste e ai progressi in specifici ambiti di realtà, che riesce difficile, se non impossibile, ricollocare tale frammentazione all’interno di un quadro sinottico che ponga la parte in relazione al tutto. Le grandi sintesi, i quadri d’insieme, le ideologie totalizzanti ed ogni altro quadro di riferimento sono scomparsi, sia a livello filosofico che scientifico che letterario.
La filosofia è andata orientandosi su una ricerca che si interroga prevalentemente sulla funzione del linguaggio; la scienza ci appare spezzettata settorialmente in varie branche, difficilmente comunicanti tra loro o totalmente autonome l’una dall’altra; in campo letterario non si scrivono più romanzi dall’impianto epico e grandioso né si pone l’accento su ideologie e valori condivisi. Tutto l’universo, che trovava, un tempo, una rappresentazione coerente nel soggetto, si riduce ora all’episodico, all’attimo di vita esperito nell’immediatezza, nell’hic et nunc, cioè, ancora, nel frammento. Indice di un depauperamento dell’orizzonte interpretativo che si concentra nella dimensione sempre più solipsistica del privato.
Neanche i poeti fanno più capo a una visione unitaria e interattiva delle loro conoscenze ed esperienze, a quella cosa che un tempo era definita Weltanshauung, l’occhio sul mondo, ma tutto il loro dire (salvo rare eccezioni) non trova espressione che nel frammento. Ma esso non è l’occhio che guarda il mondo alla ricerca della sua consistenza, di un suo essere profondo ed autentico, è semplicemente il documento e la cronaca di istanti staccati, che, perché tacciono sul resto, non ci danno ragioni della realtà rappresentata. Realtà che rimane a se stessa, non indagata, e la rappresentazione è solo riproduzione, cronaca, macchina fotografica che coglie solo uno spaccato – nei casi migliori una folgorazione- dell’intero, un frammento che, tuttavia, da solo non regge, non sta in piedi, da solo non ha senso.
Ma se le cose stanno così, direi che siamo incamminati a grandi passi verso il caos e il generale marasma perché l’uomo è, per sua natura, necessitato a dar senso alle cose: in mancanza di esso, la vita scade di livello, si perde nell’insignificanza, smarrisce la sua connotazione umana. Ogni azione dell’uomo, ogni sua decisione o scelta nascono, infatti, con una motivazione e un senso che le orienta e le muove. Il volere e il costruire qualcosa hanno sempre un senso in se stessi, una ragione e una finalità che li spinge avanti, in cerca di qualcosa da conseguire. Senza un senso, una ragione, una motivazione, nulla si genera, e l’azione, il pensiero e le scelte dell’uomo divengono nulli, invalidati dalla loro stessa insignificanza.
Heidegger parlava, profeticamente, di un progressivo allontanamento del Pensiero da quel connubio con il Canto postulati all’interno della Dichtung. Essa ci appare come il sostrato archetipico in cui Pensiero e Canto, cioè Filosofia e Poesia, si intersecano, si fondono, dialogano tra loro intimamente, inscindibilmente. In altri termini, mi pare che Heidegger individui, per così dire, una struttura portante della nostra esistenza, quella da cui dipende la nostra interazione col mondo, con la realtà che ci circonda: il Pensiero e il Canto – vale a dire la Filosofia e la Poesia – ci appaiono strutture a noi destinate nel rapportarci al mondo e nell’interpretarlo.
Ma esse si danno nell’unità della Dichtung, in questa archelingua che è la matrice comune che tesse e compenetra entrambe, rimanendo nella assoluta indistinzione da esse – fondamento che permane non scisso dai suoi elementi (descrivibili singolarmente solo a posteriori) – ma che nella sua postulazione di fondamento del dire e del pensare, allo stesso tempo li trascende, poiché in questo suo essere a fondamento, ogni pensiero e ogni dire non potranno mai ricomprenderla e riaffermala interamente. Essa rimane nel pensiero e nel linguaggio dell’uomo in un Nascondimento che mostra o in un Mostrarsi che nasconde. Ed è qui l’essenza del pensiero e del linguaggio e, se vuoi dell’esistenza intera: essa vive nell’ombra di questo Nascondimento che accenna a se stesso senza mai interamente svelarsi, è l’inesorabilità del metafisico, connaturata alle modalità di essere della nostra esistenza, è il problema dell’Origine, dove l’Aporia insormontabile è costituita dal fatto che qualunque tentativo facciamo per raggiungerla vede l’ Origine arretrare nel suo Nascondimento, e porsi sempre oltre, e sempre al di là dell’orizzonte umano.
Ma la deriva del pensiero dalla sua matrice originaria dove entra in connubio col canto, col farsi stesso della poesia, conduce con sé la deriva del linguaggio che tale pensiero esprime. Se il pensiero smette di interrogarsi e di pensare in maniera determinata e forte, se si limita ad una semplice registrazione di fatti che il linguaggio trascrive in semplice cronaca, in documentazione del frammento, senza tentare una loro interpretazione, affiorerà il linguaggio del non-senso, qualcosa di degradante per l’uomo, in quanto essere pensante, un’abdicazione alla sua stessa identità nell’inadeguato impiego dello strumento a noi dato per comprendere il mondo e per orientarci in esso.
La ricerca di nuove strade, ritenute più consone alla poesia del cosiddetto postmoderno, non può essere stabilita a priori, avendo, prioritariamente, di mira il solo aspetto formale. Imporsi nuovi schemi nell’approccio alla realtà, inventarsi il guscio di nuove formulazioni e nuove modalità o sbocchi inediti per la poesia (il più delle volte assai discutibili) non mi pare rivoluzionario per niente: è solo la constatazione che l’uomo è costretto a pensare secondo schemi -che a noi, tuttavia, sono già stati dati una volta per tutte, anzi consegnati all’Esistenza stessa insieme alle ineliminabili strutture o condizioni che fanno sì che essa sia, appunto, quella che è. In altri termini, una vera, assoluta libertà del pensare non esiste, se non eliminando il pensare stesso. A mutare sono certo i contenuti di pensiero ma non la struttura che li informa. Rimane perciò la constatazione di questa sorta di prigione o gabbia nella quale ci troviamo e della quale non possiamo liberarci finché viviamo. Tutto il resto mi pare illusorio. Non è che non vi sia il divenire, il cambiamento, esso si fa presente a noi in ogni cosa, ma non arriva a ledere mai la struttura ferrea dell’esistenza con le sue ineluttabili, ineludibili coordinate.
Quale auspicio, dunque? Abbiamo sotto gli occhi il nulla prodotto dalle avanguardie del Novecento, dallo stesso Rimbaud ci arriva il monito che se il pensiero si estranea dalla poesia, se si allontana da essa disinteressandosene, di essa non rimane che un vuoto guscio, cioè nulla.
Pertanto, è da escludere, per me, la programmatica ricerca di forme nuove nella poesia, se è una ricerca fatta prima ancora che la poesia urga nel bisogno di venire alla luce. Il divenire è connaturato a tutte le cose, è una delle ineliminabili strutture dell’esistenza stessa (che anche in questo divenire persegue un suo fine). Il poeta ha solo il compito di esprimere, nella maniera più aderente alla Dichtung heideggeriana, il suo mondo interiore (che non può essere costituito da frammenti sparsi a meno che il frammento non abbia la stessa pregnanza di senso che riscontriamo nell’enucleazione del mito, tale da renderlo per ciò stesso un emblema). E sta in questo l’unica rivoluzione che il poeta può permettersi: ma è proprio lì che una rivoluzione si compie.
Mutamento e rivoluzione sono insiti al nascere stesso della poesia, non sono elementi alienati da essa, accessori o collaterali, non precorrono il suo nascere, ma sono nell’atto stesso del suo nascere. Il rischio di costruire prima e non “dentro” alla poesia la sua particolare forma, non può che essere destinato, a mio modesto avviso, al fallimento. La rivoluzione consiste nel fatto che la forma da costruire nasce in relazione a un prodotto unico, per quella sola specie esistente, per quella particolare poesia, nella sua indissolubile comunione di anima e carne: sola ed unica come ogni individuo e come l’individuo che l’ha prodotta.
L’assoluta unicità del mondo interiore del poeta deve trovare espressione in una forma unica che è la forma di quel mondo. La sua singolare fisionomia non risiede né nella sola forma né nella sola sostanza della poesia, ma è nell’interezza che tiene immanentemente in sé la “materia” del canto e la sua forma.
Non ha senso, pertanto, assumere acriticamente da altri ciò che non ci appartiene, che nasce da un’indivudualità che non è la nostra o da un contesto sociale, politico, culturale che ci è estraneo. Assumerlo solo perché la corrente ci trascina in quella direzione, solo perché è una via da altri battuta, indicata, peggio ancora perché è “di moda”, non è un bene, non fa onore alla natura umana. Se qualcuno viene a dirci che, camminando in una certa direzione, incontreremo il baratro, vi pare più sensato scapicollarci verso di esso o tentare il più possibile di aggirarlo ed evitarlo? Quanto sta avvenendo ai nostri giorni, questo processo al quale stiamo assistendo e nel quale ci troviamo immersi, che porta ad un indebolimento del pensiero che non è più in grado di concentrarsi sui grandi temi e valori, come è stato fino al XIX secolo e in parte nel XX, è figlio del nostro tempo, di tutto ciò che caratterizza il nostro tempo: lo sviluppo tecnologico e telematico, la globalizzazione dei mercati e ciò che il capitalismo ha generato di più nocivo per l’uomo, cioè, da una parte l’asservimento al diktat del capitale, dall’altra lo sviluppo insensato del consumismo, divenuti ormai espressione di un dominio nuovo e di un asservimento alla materia e al denaro.
Lo sviluppo sempre più vertiginoso della tecnologia, il suo essere parte di questo nuovo dominio, di questo perverso ingranaggio che è la logica del Capitale con la conseguente ricaduta sulle masse nella forma imposta del consumismo, è il principale artefice della cattiva piega o, se si vuole dell’involuzione, della società ai nostri giorni. La prassi, ormai istituzionalizzata, del consumismo, mettendo tutto, e assai facilmente, a portata di mano di ognuno, da una parte ha imposto scelte che non sono più dell’individuo, ma servono il Mercato, dall’altra ha generato abulia, soprattutto intellettuale. Gli strumenti delle nuove tecnologie si sono sostituiti alle nostre possibilità di pensare, di indagare, di interrogarci. Ed è da queste premesse che il pensiero è andato via via indebolendosi e assottigliandosi sino all’inconsistenza.
Ma sta qui la rivoluzione, l’andare contro corrente: il nostro pensare non dovrebbe consistere nello “stare alla finestra” a guardare ciò che accade, a vedere il mondo transitare, a noi quasi estraneo, ma dovrebbe continuare ad interagire con esso. Pensare è esercitare le facoltà di cui si compone il pensare: l’analisi dei dati della nostra esperienza, la sintesi, l’attività critica. Non abbiamo veramente cognizione di nulla se non operiamo sintesi, accostamenti, parallelismi, analogie, se non interreliamo e incanaliamo le svariate esperienze in un processo unitario. Ci avviamo al caos, nel senso che non avremo più ragione delle cose e ne saremo allora governati, saremo in loro balia. Saremo in balia di un flusso di eventi che non potremo più dirigere e ne saremo trasportati come i cadaveri nella corrente, le foglie nel vento…
D’altra parte, questo indebolimento del pensiero – che è innanzi tutto delle masse- è andato progressivamente accentuando il divario, all’interno del sistema dei saperi e delle conoscenze umane, tra i pochi che la cultura detengono e determinano, e la posizione, sempre più amorfa, superficiale, non creativa e non intimamente coinvolta delle masse, istituendo, in tal modo, un diaframma tra attori e spettatori del sapere ma anche del mondo, tra chi ne detiene il dominio e chi lo subisce, anche se nell’ambito culturale agiscono per lo più fattori non prettamente culturali, ma relativi alle direttive della macroeconomia globale e del Mercato. La loro onnipotenza e quella della finanza induce alla constatazione di una implicita sudditanza delle masse, e del plagio della volontà che a loro pertiene, manipolata, appunto, e sostituita dai poteri forti, inarrivabili dell’economia e della finanza globalizzate.
Le Nazioni stesse che, un tempo, svolgevano un ruolo determinato e peculiare nell’orbita della politica internazionale, ora, per la politica globalizzata che ne consegue, si allineano allo stesso ruolo degli individui, divenendo essi stessi parte di una massa senza volto e senza identità: esattamente come gli individui hanno perduto la loro individualità, non sono più tali, ma numeri asserviti ad una perversa incoercibile forza.
L’ottimismo con cui Vattimo e tanti altri – filosofi e non- guardano al postmoderno (con la morte di Dio e della metafisica e dei grandi sistemi di pensiero ecc.) mi appare abbondantemente contraddetto e destituito di valore dagli innumerevoli efferati accadimenti in corso, come le tante guerre combattute e senza via d’uscita, e le tante disparate nefandezze che affollano le cronache dei giornali quotidianamente, cronache che investono ambiti e istituzioni la cui lungimiranza era un tempo garanzia inoppugnabile, e che vanno ad intaccare, ora, in maniera definitiva, la consistenza stessa dei principi più irrinunciabile dell’etica umana. E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che le vicende dei nostri tempi, gli accadimenti nei quali ci troviamo immersi, coinvolti, contravvengono platealmente al pensiero di un rinnovato umanesimo, più laico, più sregolato, più libertario e all’insegna del buonismo e del mite godimento di quel che la realtà ci offre, come lo stesso Vattimo aveva preconizzato. E con questo, siamo proprio nella direzione di quel minimalismo che il sistema predilige, ricercando l’assuefazione e la sottomissione e la non emancipazione delle masse, che è necessario assoggettare.
Il divario apertosi tra i pochi che detengono un dominio e chi tale dominio subisce, tra mondo egemone e mondo assoggettato, si è andato poi esasperando a tutti i livelli di realtà riflettendosi in ogni suo aspetto. Gli stessi filosofi brancolano nel buio. I veri depositari di un sapere ancora credibile, sono, appunto, coloro che operano senza un fondamento del loro sapere cioè gli scienziati. Essi, infatti, non si interrogano sul fondamento della realtà che indagano. Ma a loro, in qualche modo, si crede, da loro si attende, a loro è demandata la rifondazione di una scienza sulla base di un nuovo fondamento o sulla riconferma di quello che è stato dal sapere stesso sconfessato.
Insomma, invertito il processo, si torna a ciò da cui il pensiero, anticamente, aveva preso le mosse, si torna alla riproposizione della questione dell‘Origine, al problema dell’Essere e della realtà. Infatti, le grandi interrogazioni degli scienziati, al giorno d’oggi, mi pare vertano proprio su questo punto nodale, il primo e il solo punto indagato nelle lontanissime origini del pensiero stesso. Questo è, per me, la riprova dell’impronta teleologica dell’universo, come se una sua logica interna, un pensiero immanente ad esso ci indirizzasse all’Oltre, in un processo di Immanenza/Trascendenza che rimane la radice dell’Universo stesso, o che dir si voglia, di Dio. Infatti, comunque si attui questa ricerca, sia che parta da un’indagine sul suo fondamento, sia che parta dalle cose stesse, dall’Essere o dall’ente, essa conduce sempre ad additare un Oltre, che si colloca, irrimediabilmente, al di là delle coordinate esistenziali, come se il fondamento dell’esistenza di fatto, e delle facoltà interpretative con le quali ci orientiamo in seno ad essa, fosse quel limite dal quale l’”Esserenascosto” accenna a se stesso senza mai rivelarsi.
Mi appare allora inevitabile il parallelismo tra Immanenza/Trascendenza e tra Linguaggio umano (pensiero-canto)/Dikthung (heideggeriana). Il pensiero di Heidegger, a riguardo, mi è sempre apparso controverso: da un lato, infatti, sembrerebbe additare la Dikthung come comune immanenza all’interno sia del Pensiero che della Poesia, dall’altro, vivendo essi nella luce di essa senza mai identificarsi con essa (che rimane inattingibile e nascosta), sembrerebbero additare la trascendenza stessa della Dikthung che nel suo mostrarsi attraverso il linguaggio, come espressione e del Pensiero e del Canto, allude a se stessa senza mai dichiararsi, rimanendo “dietro le quinte” per così dire, essenza stessa di un linguaggio – quello umano, naturalmente- che nel momento in cui dice, determina e circoscrive togliendo già, dall’oggetto indicato e circoscritto, tutto l’altro che rimane al di là della sua determinazione.
Il rapporto Immanenza/Trascendenza, sarebbe poi, tradotto in altri termini, il rapporto che lega parallelamente e dialetticamente l’Esistenza all’elemento che la trascende e che ad essa si impone, vale a dire, il Trascendente, l’Oltre, che per quanto ci adoperiamo a negarlo, sempre risorge, sempre accenna a se stesso in quel Nascondimento/Disvelamento che gli è proprio. Ma tale rapporto, che a noi si mostra come parallelo e dialettico, verrebbe ad esprimere una Identità, una eguaglianza fondamentale poiché, solo nello iato che è l’esistenza, l’Immanenza/Trascendenza, –ovvero il Nascondimento che si disvela e il Disvelamento che in se stesso si ritrae, nascondendosi a noi- si mostrano come distinti.
Rossella Cerniglia








